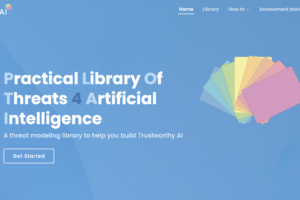Putin cerca di controllare la messaggistica istantanea?
Negli ultimi anni, la Federazione Russa ha progressivamente rafforzato il proprio controllo sulle infrastrutture digitali e sulle comunicazioni elettroniche, in linea con una visione autoritaria della cosiddetta cybersovranità. L’introduzione di una piattaforma di messaggistica statale, che va a inserirsi in un contesto già segnato da restrizioni e blocchi a danno di media e servizi occidentali, rappresenta un ulteriore passo verso un sistema digitale chiuso, simile a quello cinese. Tale evoluzione solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra sicurezza nazionale, diritti fondamentali e architettura tecnica della rete, soprattutto nel contesto di un conflitto geopolitico prolungato e di una crescente tensione tra potenze globali.
Secondo quanto riportato dal New York Times nell’articolo “Putin Widens Effort to Control Russia’s Internet”, il governo russo ha promosso una nuova applicazione di messaggistica approvata dallo Stato, sviluppata da entità vicine al Cremlino, la quale potrebbe presto diventare l’unico strumento legittimo per le comunicazioni digitali. L’annuncio è stato accompagnato da segnali di possibile censura nei confronti di servizi popolari come WhatsApp e Telegram, nonostante quest’ultimo sia di origine russa. L’obiettivo esplicito è quello di “proteggere” i cittadini da influenze esterne, ma l’effetto concreto è quello di limitare drasticamente la libertà di espressione e il pluralismo informativo.
Il controllo delle infrastrutture di rete rientra in una strategia più ampia che la dottrina russa definisce come “sovranità informativa”. Tale concetto, sviluppato a partire dagli anni Duemila e codificato nella normativa interna con la legge sulla “Internet sovrana” del 2019, attribuisce allo Stato il potere di isolare il Runet (l’internet russo) dal resto della rete globale, attraverso la costruzione di DNS autonomi e la gestione centralizzata del traffico dati. In questo quadro, l’introduzione di una app di messaggistica nazionale costituisce un tassello coerente con l’obiettivo di esercitare un controllo end-to-end su comunicazioni e flussi informativi.
L’impatto di tale strategia è duplice. Da un lato, si assiste a un rafforzamento della capacità dello Stato di monitorare e reprimere il dissenso, come evidenziato dalla crescente criminalizzazione dei contenuti ritenuti “estremisti” o “antipatriottici”, spesso definiti in modo vago e arbitrario. Dall’altro lato, emerge una trasformazione strutturale dell’ecosistema digitale, che si allontana dal modello aperto e interoperabile su cui si è basato storicamente l’internet globale. In tal senso, la Russia non è un caso isolato: le politiche adottate da Mosca trovano eco in tendenze analoghe in altri contesti autoritari, come la Cina o l’Iran, ma anche in certe derive securitarie osservabili in democrazie illiberali.
L’approccio russo si colloca inoltre in tensione con il diritto internazionale dei diritti umani. Come stabilito dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, l’accesso a internet è parte integrante del diritto alla libertà di espressione sancito dall’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Le restrizioni sistemiche e arbitrarie imposte alle piattaforme di comunicazione rappresentano quindi una potenziale violazione degli obblighi internazionali della Federazione Russa, nonostante le riserve sovraniste avanzate da Mosca. In ambito europeo, tali pratiche sarebbero incompatibili con l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di ricevere e diffondere informazioni senza interferenze da parte delle autorità pubbliche.
Un ulteriore aspetto da considerare è il ruolo dell’architettura tecnica nella produzione di normatività. La progettazione di infrastrutture digitali statali implica una codificazione “by design” di principi autoritari: tracciabilità obbligatoria, assenza di crittografia end-to-end indipendente, sorveglianza sistemica. In tale contesto, il codice diventa diritto, secondo la nota formula di Lawrence Lessig, ma un diritto al servizio dell’apparato repressivo, anziché della cittadinanza.
In conclusione, la progressiva “nazionalizzazione” delle comunicazioni digitali in Russia segna una tappa significativa nella ridefinizione autoritaria della governance di internet. A fronte di ciò, si impone una riflessione più ampia sul ruolo che l’Unione europea e altri attori democratici possono svolgere per promuovere un cyberspazio aperto, resiliente e rispettoso dei diritti fondamentali, contrastando efficacemente le derive tecnocratiche e censorie che minacciano l’architettura globale della rete.
Tag:controllo, data protection, messaggistica, privacy, putin, Russia