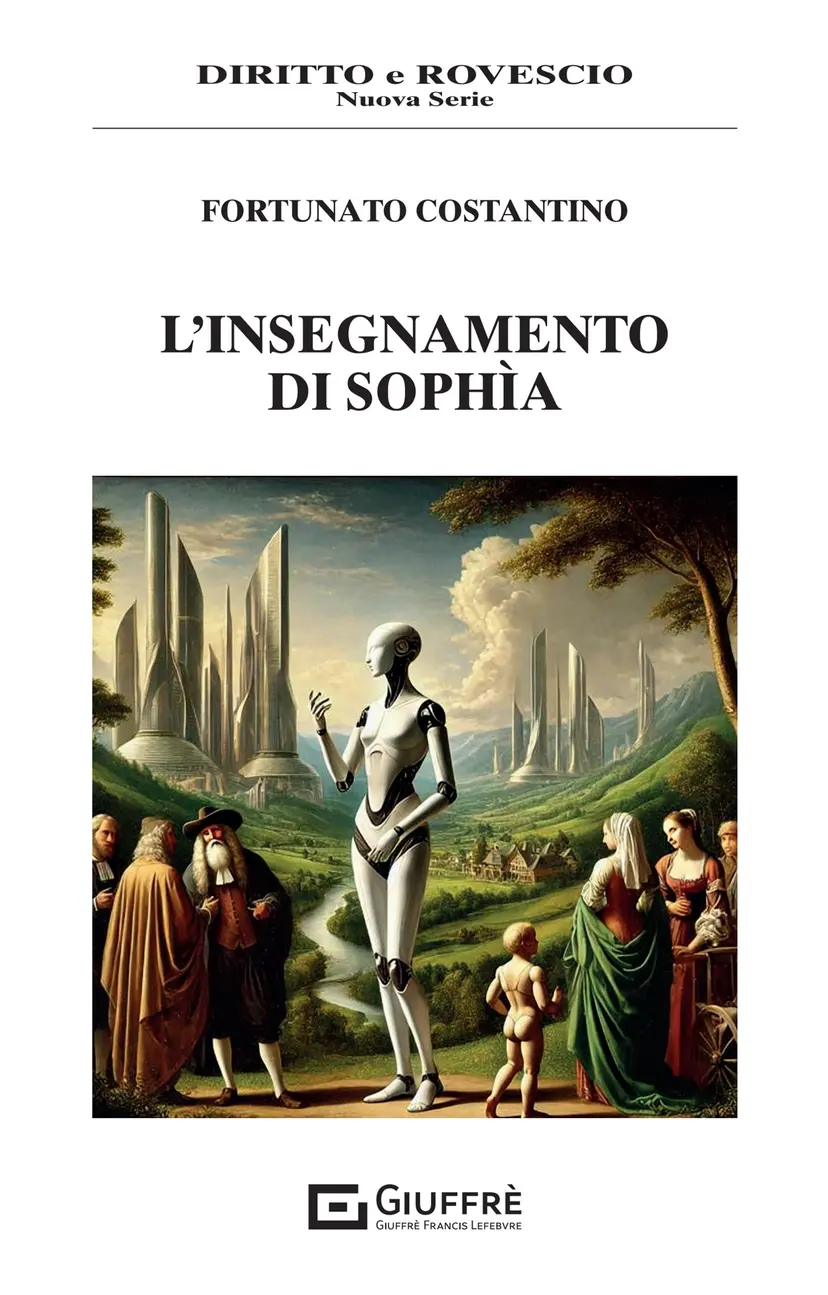Recensione del volume di Fortunato Costantino, L’insegnamento di Sophìa
Nel panorama editoriale contemporaneo, saturo di pubblicazioni sull’intelligenza artificiale, L’insegnamento di Sophìa di Fortunato Costantino si distingue come un’opera tanto necessaria quanto originale. Lungi dall’aderire alle due narrazioni dominanti – l’ottimismo ingenuo che mitizza la tecnologia come soluzione a ogni male e il catastrofismo tecnofobo che la dipinge come una nuova Medusa digitale – il volume propone un percorso riflessivo, quasi meditativo, capace di rimettere al centro della discussione ciò che troppo spesso viene trascurato: l’Uomo.
Costantino sceglie la forma della novella filosofica, o meglio ancora della “novella cyborg”, per affrontare le questioni più urgenti e spinose legate all’intelligenza artificiale. La struttura narrativa, volutamente essenziale e a tratti dialogica, si snoda attorno all’incontro di tre personaggi emblematici: un tecno-scienziato, una filosofa e una super intelligenza artificiale. L’interazione tra queste tre voci – ognuna portatrice di un approccio diverso e complementare – diventa il vero cuore pulsante dell’opera. In questa triangolazione si sviluppa un confronto che non ha nulla di retorico o precostituito, ma che anzi si alimenta di dubbi, domande aperte, tensioni irrisolte. Il lettore si trova così coinvolto in un percorso di consapevolezza che lo invita a interrogarsi sul senso della tecnica, sui limiti del progresso e, soprattutto, sul ruolo imprescindibile del pensiero umano in un’epoca in cui tutto sembra accelerare verso l’automazione totale.
Il contesto in cui si inserisce L’insegnamento di Sophìa è quello di un dibattito pubblico sempre più polarizzato. Da un lato, mercati e consumatori – sedotti dal miraggio dell’innovazione permanente – rincorrono un surplus tecnologico fondato sull’assunto, spesso infondato, che più tecnologia significhi automaticamente più benessere. Dall’altro, una parte della comunità scientifica e intellettuale lancia l’allarme sull’avvento dell’“algocrazia”, ovvero quel sistema decisionale dominato dagli algoritmi, che rischia di sottrarre all’essere umano la capacità di autodeterminazione, dissolvendone la responsabilità morale e civile. In mezzo a questi due estremi, Costantino si propone di costruire un terzo spazio: uno spazio di riflessione critica, che non rifiuta la tecnologia ma nemmeno la adora, che ne riconosce la potenza trasformativa ma anche l’ambivalenza, e che si interroga su quali strumenti di governance possano permetterci di non esserne schiacciati.
In questo senso, L’insegnamento di Sophìa è anche un’opera profondamente politica. Lo è non perché assuma un tono ideologico, ma perché restituisce dignità alla domanda più urgente di tutte: quale posto vogliamo che l’essere umano occupi nel mondo che verrà? E, ancora più radicalmente: quale visione dell’umano siamo disposti a difendere nell’era delle intelligenze artificiali? La Sophìa del titolo non è solo un personaggio, ma un simbolo. È la sapienza che deriva dal dialogo, dalla ricerca di senso, dall’incontro tra sapere tecnico e sapere umanistico. È la possibilità, tutta da costruire, di un equilibrio tra l’istanza della potenza e quella del limite.
La scrittura dell’autore si distingue per eleganza e sobrietà. Il linguaggio è chiaro, ma mai semplicistico; denso, ma mai opaco. Si percepisce la mano di un autore abituato a pensare in profondità, ma anche attento a non rinchiudersi in un tecnicismo autoreferenziale. Al contrario, ogni pagina sembra concepita come un invito alla condivisione del pensiero, un gesto di apertura che chiede al lettore di diventare parte attiva della riflessione. Il tono è filosofico, ma non accademico; narrativo, ma mai evasivo. Questo equilibrio tra rigore e accessibilità fa di L’insegnamento di Sophìa un’opera adatta sia al lettore esperto che desideri un confronto stimolante, sia a chi si avvicina per la prima volta alle grandi questioni poste dall’IA.
Un altro merito del libro è la sua capacità di far dialogare dimensioni che spesso restano separate: la scienza e la filosofia, l’etica e la tecnologia, l’immaginazione e il realismo. Lungi dal proporre una visione utopica o distopica, Costantino ci offre uno sguardo lucidissimo sul presente e sul futuro prossimo, svelando le contraddizioni di una società che rischia di delegare alle macchine non solo il lavoro e le decisioni, ma anche l’interpretazione del mondo. In questo quadro, la proposta dell’autore è chiara: serve una nuova alfabetizzazione etico-tecnologica, capace di restituire all’Uomo la consapevolezza della propria irripetibilità e del proprio ruolo nel presidiare – con responsabilità e senso del limite – l’orizzonte tecnologico.
In conclusione, L’insegnamento di Sophìa è un testo che colpisce per la sua originalità e profondità. Non è solo un racconto filosofico, ma un dispositivo critico, una lente attraverso cui osservare con maggiore consapevolezza il nostro tempo. In un’epoca in cui tutto corre e si semplifica, il libro ci invita a rallentare e a pensare. A pensare davvero. E lo fa con la grazia e la fermezza di chi crede, con rara lucidità, che solo un’alleanza rinnovata tra sapere tecnico e sapere umanistico potrà guidarci verso un futuro che non sia soltanto più efficiente, ma anche – e soprattutto – più umano.